Questa è stata la mia prima traduzione.
Calamity Jane
Lettere alla figlia, 1877-1902
Introduzione di Katia Bagnoli
Traduzione di Gabriella Agrati e Katia Bagnoli
Milano, Edizioni delle donne, 1979
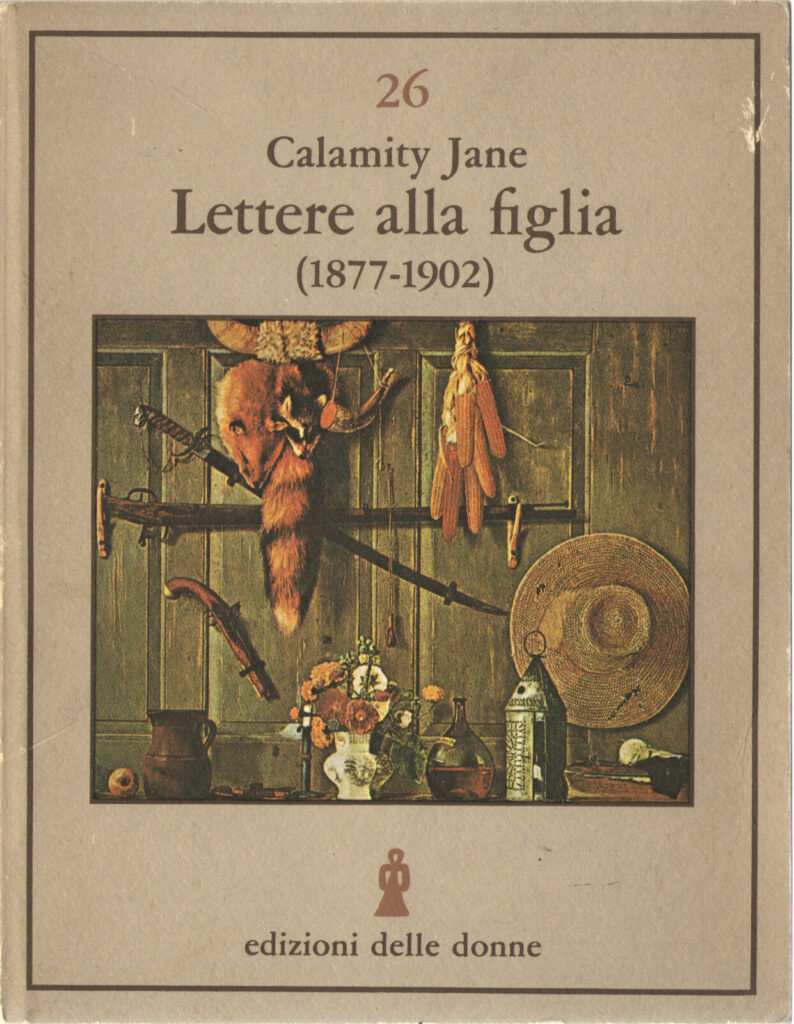
Martha Jane Cannary, detta Calamity Jane, nata nel 1852 e morta nel 1903, è una figura leggendaria del West della Frontiera. Conducente di diligenze, scout, giocatrice d’azzardo, cercatrice d’oro, prostituta, e anche infermiera, cuoca, lavandaia e donna di spettacolo, sposò lo sceriffo James Butler Hickok, il celebre Wild Bill, da cui ebbe la figlia Jean. È a quest’ultima, affidata a genitori adottivi, che Calamity indirizza, tra il 1877 e il 1902, il suo diario-epistolario.
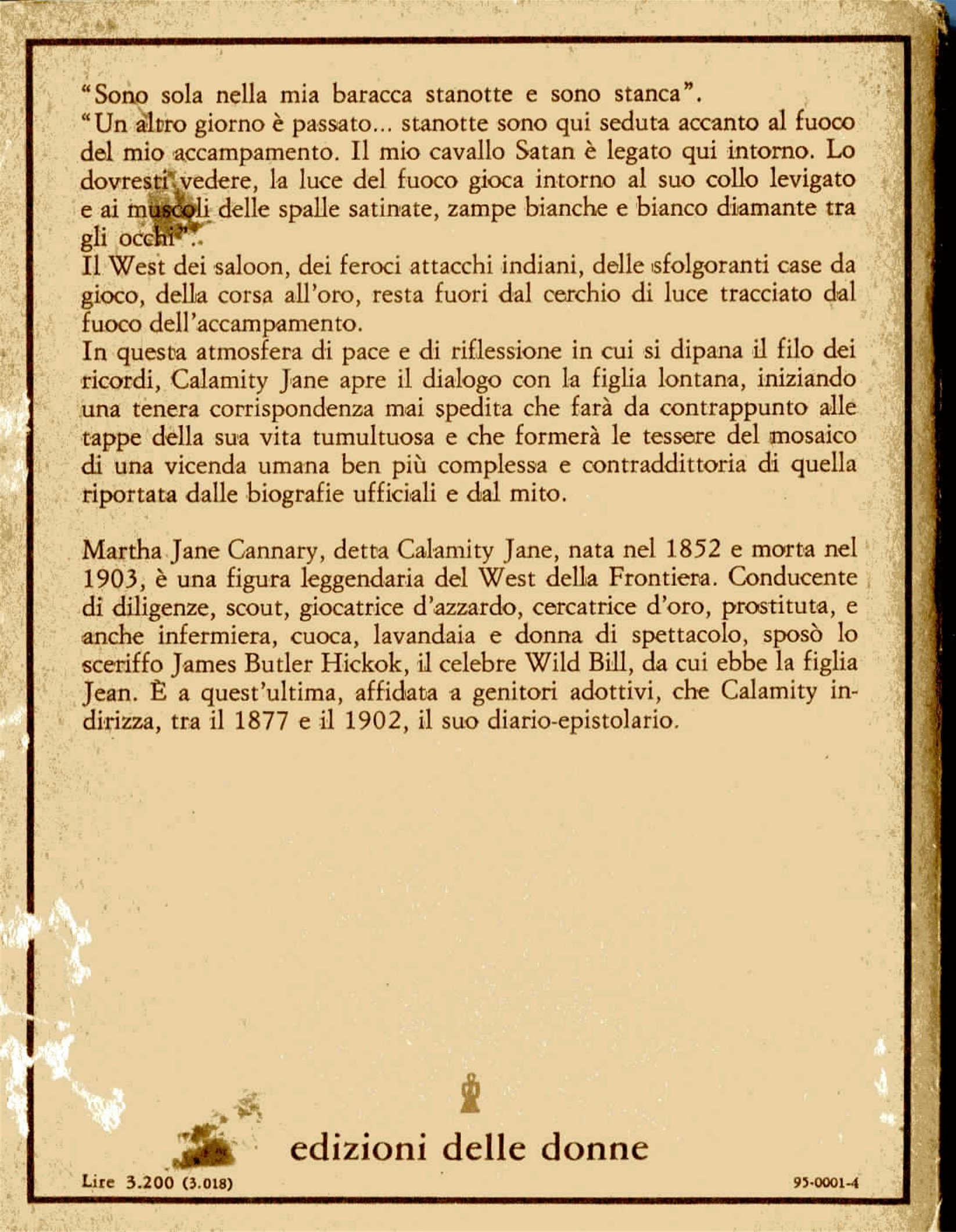
Introduzione di Katia Bagnoli
Calamity Jane, al secolo Martha Jane Cannary, nasce a Princeton, Missouri, il 1° maggio 1872. Nel 1863 la famiglia si trasferisce nel Montana, poveri agricoltori contagiati dalla febbre dell’oro.
Più tardi, alta, bionda e travestita da uomo, Calamity si arruola nell’esercito degli Stati Uniti, ma si tradisce e viene allontanata: come Achille in panni muliebri ingannava il suo destino, così Calamity, in pantaloni virili, trasgredisce il proprio: ma entrambi furono scoperti. Pare che scazzottasse uomini importuni, che cavalcasse tori a Rapid City, e che togliesse tanto di cappello, con uno sparo, a individui poco garbati. Alimentò lei stessa la propria leggenda, stampando in proprio e smerciando di persona una succinta storia della sua vita.
Una patina di oleografia spessa due dita grava sui cinquant’anni circa della sua esistenza, ovvero: sotto la dura scorza dell’avventuriera batte un cuore di mamma, di infermiera, di eroina di stampo manicheo, con qualche macchia e nessuna paura, la quale, certo, sarà costretta a vendere, all’occasione, il suo corpo, ma è sempre disponibile come benefattrice, una vera Madonna che togliendosi il pane di bocca sfama interi villaggi di minatori.
Nella versione fumettistica che ce la esibì negli anni cinquanta al fianco dell’eroe Pecos Bill, Calamity Jane appare stupendamente acconciata, elegante nel rozzo indumento cowboy, con dei boccoli alla Rossella O’ Hara; biondi però, alla Marilyn Monroe, dotata di telepatiche nonché medianiche virtù mentre quell’angelo di Pecos Bill da paradisi di purezza piomba sulle spalle del male e lo sconfigge: coadiuvato, si capisce, dalla platinata Calamity. E così via secondo le dizioni di relatori che non l’hanno mai vista, dove l’unicità peculiare di un destino umano lascia il campo al pittoresco delle sue esagerazioni; dove una vita, certo intrisa di leggenda, e magari fittizia, trascolora, in quel West oscuramente storico, fino ad assottigliarsi in remoti bisbigli e incomprensibili augh.
Ma Calamity ha scritto un diario. Quando la vacillante grafia del suo pugno colpisce sulla faccia il mare dell’imbecillità che ce la adulterava, ecco le acque calmarsi ed emergere, se non una circostanziata e credibile biografia, quantomeno il timbro di una voce viva, drammaticamente vibrata sulle sue stesse contraddizioni; un linguaggio diretto che non fuga, per quel che valgono, le male fame fiorite intorno al personaggio (moralità incerta, protervia, sessualità generosa, bordello); una lingua che soffre e implora, gioisce e impreca: si rivela autentica, anche ‒ o proprio ‒ nelle palesi menzogne: ci parla di Calamity perché Calamity la parla. E, oblique di una sintassi nata tra la terza elementare e l’aleatorio universo linguistico del West, ecco che frasi singolarmente forti si stagliano sovente contro periodi lambiccati e criptici; ecco scene di vita, allontanate e rese stranamente vicine dalla “tecnica” retrospettiva delle rievocazioni rivissute, o folgorante a mente fresca quasi sull’accadere, magari la sera, intorno a un fuoco di campo, o previste, predeterminate (“domani vincerò 20000 dollari”) secondo l’imperscrutabile sicurezza di chi si inventa un destino.
Ecco ‒ no, non certamente la voce dello storico, ma una voce storica, che ci tramanda le avventure minime di una comunità in divenire, di un’America giovane e tuttavia già ben piantata, con l’impiegato delle poste che sbircia tra la corrispondenza, i reverendi d’assalto, tutti d’un pezzo, che bazzicano i saloon e benedicono tra le sparatorie, e via dicendo finché al pionierismo romantico subentra una classe ormai borghesemente determinata (vedi le donne che tentano di buttar fuori Calamity da un locale pubblico in quanto diversa, forse puttana, chissà, ma Calamity sempre rifiuta questa qualifica professionale).
Ebbene, in queste pagine è profusa una sensibile facoltà espressiva: su luoghi di sapore conviviale gittano confessioni d’artesiana vena, niente viene descritto e tutto è vivificato, vi sono passaggi inconsapevolmente, quasi, simbolistici (scena del matrimonio con Bill Hickok) e, perché no, dadaistici: con quelle madornali ricette culinarie la cui esecuzione richiederebbe credo più coraggio di una sortita tra i Sioux.
Resta il punto segreto, il mistero, il centro verso cui convergono tutte queste parole: l’altro, la figlia, immagine speculare del sé, Jane O’Neil, inalienabile polo di una comunicazione alienata.
Questa figlia è uno spettro: interlocutrice impossibile, destituita della sua carnea realtà e idealizzata in forma di foglio bianco: sopra cui scrivere (vivere) la propria vita: prossima alla morte, questa strana madre scriverà: “io credo che il mio diario sia quasi finito” (diario dunque, e non vita).
Così, per ammaestramento e amore della figlia, Calamity svolge, fissa, proprio quanto, al di sopra del controverso quotidiano, lei crede debba essere salvato: mere particelle, rese significative mediante l’esclusione del resto: e nega a queste lettere la natura di corrispondenza, le sottrae alla cerimonia del recapito, per rinviare, evitare l’incontro con colei che non dovrà rispondere né giudicare, bensì accettare, in virtù della morte, l’immagine che, strutturata a forza di esclusioni, la madre le aveva dedicato.
Compare un giorno nel West una donna che dice di chiamarsi Jane O’Neil, e domanda notizie di Calamity, e sostiene di essere sua figlia; e suo marito chiede e ottiene il divorzio, perché ha sentito spettegolare e i pionieri del passato non sono più di moda, e chissà che strana bestia era questa Calamity, madre di sua moglie, pistolera famosa, gambling woman, ubriacona fottuta.
Se l’apparizione di uno spettro desta, in genere, qualche perplessità, quella di Jane O’Neil ne scatena un vespaio. Che la ragazza rispondesse a quel nome lo attesta anche l’anagrafe, ma ‒ proprio ‒ noi non sappiamo se l’avesse partorita Calamity. Perplessità fomentate dai frammenti estremi del diario: che si fa a un tratto reticente, che si tortura per non confessare, quando di confessare ha voglia, smania persino: “Ho da dirti qualcosa e se lui (papà Jim O’Neil) è d’accordo, può dirtela”. “Porto molti segreti con me Janey”, “C’è qualcosa che dovrò confessarti ma proprio non posso. Lo porterò con me nella tomba. Perdonami e considera che ero sola”.
Quanto ci resta è dunque un continuato gesto di purificazione, un depurare l’esistenza con i filtri della censura di ritorno, a colpi di discolpa, affastellando eventi, verità e menzogne, onde trasfigurare vita e leggenda in un’altra vita e in un’altra leggenda, in quell’America puberale, dove esistere è un misterioso affare e l’individuo viene e passa senza aver lasciato traccia: “Mi piace questo paese ma finirò con l’odiarlo perché mi ha strappato tutto quello che amavo”.
Calamity diventa cieca (“il dottore mi ha detto che fra due mesi lo sarò completamente”) e ne deduce che la vita scompare, scomparendo il dono della scrittura: “Ci vedo appena per poter scrivere questo. Ogni speranza è morta per sempre Janey. Lascio soltanto queste piccole fotografie di te e di tuo padre… Oh come vorrei avere la mia vita da rivivere ancora”.
Katia Bagnoli
Nota: L’impossibilità di riprodurre, senza effetti di grottesca forzatura, il personalissimo sincopato del testo originale, basato su una gamma davvero espressiva di ingenuità ortografiche, sintattiche e grammaticali, ci ha indotto a emendare quegli “errori” che la nostra lingua non avrebbe accolto senza vistosi effetti di forzatura e grottesco; abbiamo tuttavia cercato di preservare, dove possibile, il “parlato” di C. J.; così come si sono mantenuti inalterati nomi propri, toponimi e punteggiatura “cantata”.
K. B.

